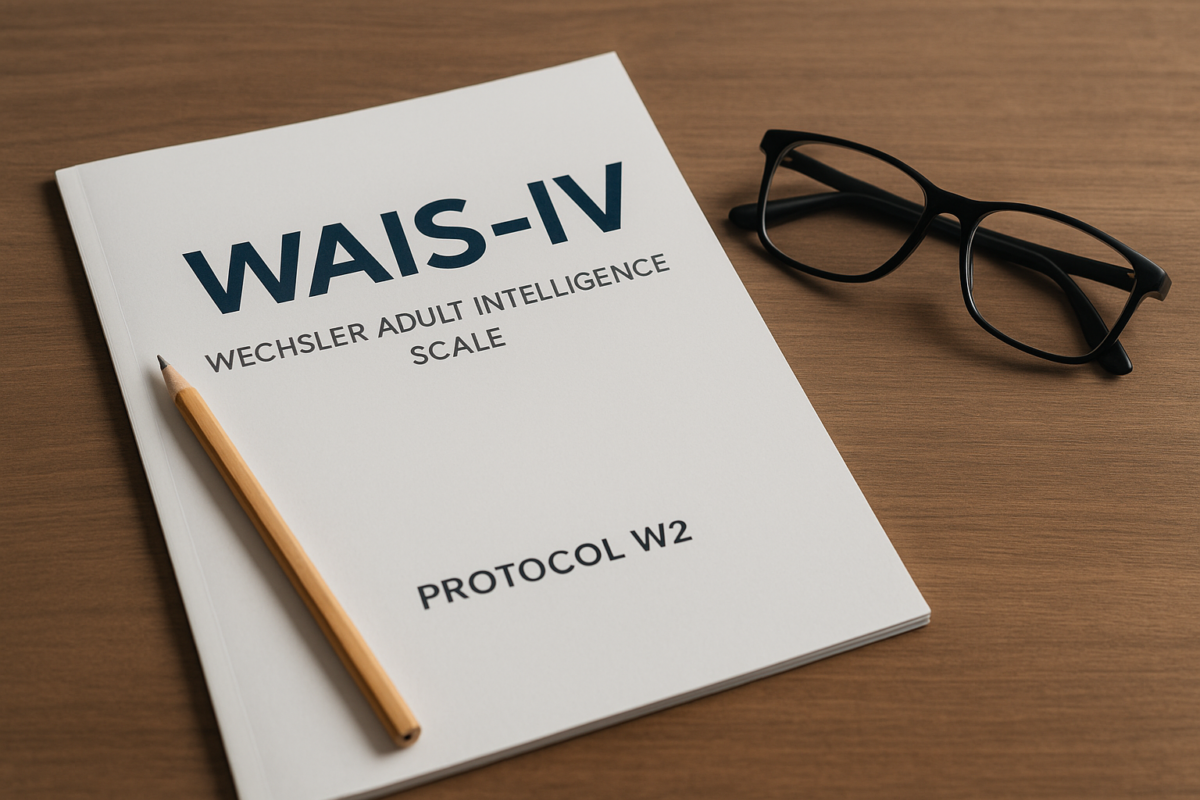Test, valutazioni e strumenti diagnostici
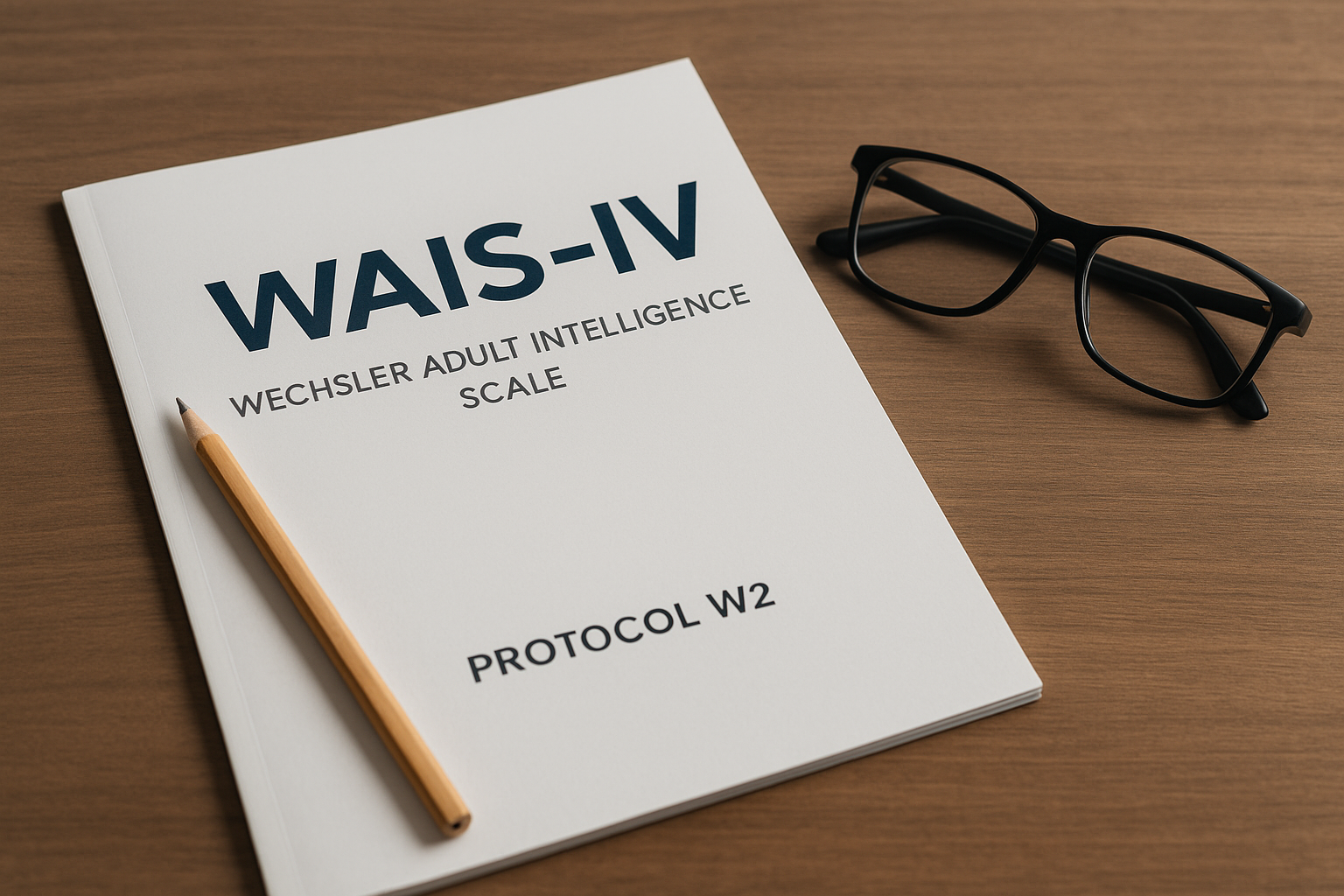
Perché parlarne
Molti arrivano a chiedersi se siano gifted solo in età adulta inoltrata, magari spinti da un senso di diversità, da fatiche ricorrenti o da intuizioni nate leggendo articoli e libri sull’argomento. A quel punto, la domanda successiva è quasi inevitabile: “Come posso capirlo in modo più chiaro? Quali strumenti esistono per valutare la giftedness in età adulta?”
La risposta non è semplice, perché gli strumenti diagnostici non sempre sono stati pensati per gli adulti, e richiedono un uso attento e contestualizzato.
1. I test di intelligenza classici
I più noti sono i test di quoziente intellettivo (QI), come la WAIS-IV (Wechsler Adult Intelligence Scale).
Possono offrire un’indicazione dei punti di forza cognitivi, come memoria di lavoro, ragionamento logico, velocità di elaborazione.
Tuttavia, hanno limiti importanti: sono stati costruiti per rilevare difficoltà o differenze cliniche, non per misurare la complessità della mente gifted.
Nei gifted possono emergere profili disomogenei: punteggi molto alti in alcune aree e medi in altre, che rischiano di abbassare la media complessiva, nascondendo la reale intensità cognitiva.
2. Test complementari e indici qualitativi
Accanto ai test di QI, esistono strumenti che possono integrare la valutazione:
Questionari di auto-valutazione (come l’OEQ-II, Overexcitability Questionnaire) che esplorano le intensità emotive, sensoriali e cognitive.
Scale di creatività e problem solving, per osservare aspetti non sempre misurabili dal QI.
Interviste cliniche e anamnesi approfondita, che raccolgono la storia personale, scolastica e lavorativa. Questi strumenti aiutano a leggere i dati quantitativi dentro il vissuto della persona.
3. Il ruolo del contesto
Un test da solo non basta a “definire” la giftedness.
È fondamentale che i risultati vengano letti da un professionista esperto di neurodivergenze e giftedness negli adulti, capace di cogliere i tratti qualitativi (ipersensibilità, velocità di pensiero, intensità emotiva).
L’interpretazione clinica deve guardare al percorso di vita: successi, difficoltà, strategie usate, ambienti di crescita.
4. I limiti dei test standardizzati
Non catturano curiosità insaziabile, creatività, intuizione.
Possono generare ansia da prestazione, soprattutto in chi già lotta con la sindrome dell’impostore.
Rischiano di ridurre la complessità a un numero, se non accompagnati da una lettura più ampia.
5. Valutazione come processo, non come etichetta
Una buona valutazione non si riduce al punteggio finale. È un processo che può aiutare a:
ricostruire il senso della propria storia,
dare parole a vissuti interiori spesso rimasti senza nome,
individuare risorse e strategie di autoregolazione,
aprire nuove strade di autorealizzazione.
6. Alternative e complementi ai test
Per alcune persone, può non essere necessario o utile passare da una valutazione formale. Alternative o complementi possono essere:
auto-riflessione guidata con libri, articoli e strumenti pratici,
percorsi terapeutici dedicati agli adulti gifted,
spazi di confronto tra pari, dove riconoscersi in esperienze simili può già essere trasformativo.
Conclusione
I test possono offrire chiarezza, ma non sono l’unica via. La giftedness non è un numero, ma un modo di vivere il mondo: un insieme di intensità, sensibilità e slanci che non sempre rientrano in schemi standardizzati.
Per questo, più che chiedersi “Quanto è alto il mio QI?”, la domanda più preziosa diventa: “Quali aspetti della mia mente posso riconoscere, accogliere e valorizzare, per vivere con più autenticità e benessere?”
ACT, mindfulness e self-compassion possono aiutare proprio in questo: fare amicizia con la propria mente intensa, integrando sia i suoi punti di forza che le sue vulnerabilità.
Se ti interessa approfondire se fare o meno una valutazione (io non le eseguo) o se vuoi affrontare come ti senti indipendentemente dal certificato, scrivimi qui sotto: